
Il gruppo PAGE in trasferta a Benevento: riflessione collettiva sull’esperienza del primo congresso SIDEA-SIEA-CESET
A cura di Luciano Pagano, Sabrina Tomasi, Benedetta Bernardini, Selene Righi, Daniele Vergamini, Fabio Lepore, Sonia Massari, Livia Ortolani
Dal 2 al 4 luglio, una piccola delegazione del gruppo PAGE ha preso parte al primo congresso congiunto delle Società scientifiche SIDEA, SIEA e CESET, ospitato nello storico Complesso di Sant’Agostino a Benevento e organizzato dall’Università degli Studi del Sannio. Tre giornate intense, dense di scambi e di connessioni disciplinari, dedicate al tema “Territori, Cibo e Società. Tra sfide globali e complessità”.

Benevento ci ha accoltɜ con il grande calore del suo centro storico e delle sue emergenze culturali, con le luci e i colori della festa patronale del quartiere della Madonna delle Grazie. Abbiamo sentito un richiamo costante – grazie alla cura del comitato organizzatore del Convegno nella scelta di accompagnarci alla scoperta dei paesaggi e dei sapori e di mostrarci il filo continuo che lega la città di Benevento all’area rurale e interna del Sannio – al ruolo che la stessa università gioca come presidio territoriale e istituzione in dialogo con il contesto.
Questa è stata la cornice ideale per un calendario serrato di lavori che ha saputo dosare confronto accademico e convivialità. Sin dalla plenaria inaugurale è emerso un invito a “fare sistema”, a innescare collaborazioni: la complessità che lega territori, cibo e società può essere attraversata solo con la costituzione di reti di ricerca – interuniversitarie e interdisciplinari – capaci di dialogare con gli attori locali, promuovendo transizioni attente alle specificità di ogni area.
Le tre giornate sono state scandite da plenarie di ampio respiro, ben bilanciate tra le istanze complementari delle diverse società coinvolte.
Bettina B. Bock (Università di Groningen) ci ha proiettatɜ verso possibili “futuri rurali” in un mondo in rapida trasformazione, riprendendo la necessità di puntare sulla valutazione e adattamento partecipato delle politiche rurali per misurarne gli impatti e adeguarle alle esigenze locali, in collaborazione e con il coinvolgimento delle comunità.
Mario Mauro (Università degli Studi di Firenze) ha mostrato come i partenariati pubblico-privati possano tradursi in governance efficaci.
A seguire, la tavola rotonda moderata da Vladi Finotto (Università Ca’ Foscari di Venezia) con Serena Pittella, Sara Roversi e Cosimo Rummo, ha dato voce ad esperienze italiane sul contributo delle imprese agroalimentari al rinnovamento di territori e società, con un focus sull’imprenditorialità rurale e nel rurale.
Al contempo, le ricchissime sessioni parallele hanno approfondito questioni chiave: dall’adattamento al cambiamento climatico alla gestione dell’acqua, al consumo del suolo e urbanizzazione; dalla sperimentazione di nuovi modelli di governance e politiche agricole e rurali, fino al ruolo del terzo settore e dell’innovazione sociale nelle filiere corte e nell’economia circolare; dalla didattica alla segmentazione dei mercati nei sistemi agroalimentari, fino all’innovazione multidimensionale, compresa quella digitale, nelle aree rurali.
Durante le tre giornate, il gruppo ha presentato all’interno di diverse sessioni. Selene Righi ha partecipato alla sessione su “Cambiamento climatico e resilienza territoriale” con una presentazione dal titolo “The ecological transition of livestock farming system: a strategic opportunity for Italy”.

Luciano Pagano ha presentato nella sessione su Politica agricola e rurale il caso “Analysis of soil health business models from an environmental and socioeconomic perspective: a Tuscan case study”, mentre Fabio Lepore ha portato il suo contributo “Adaptive Cost-Benefit Analysis as a new holistic approach for assessing digitalisation in socio-ecological systems” nella sessione dedicata all’Economia circolare e transizione ecologica.
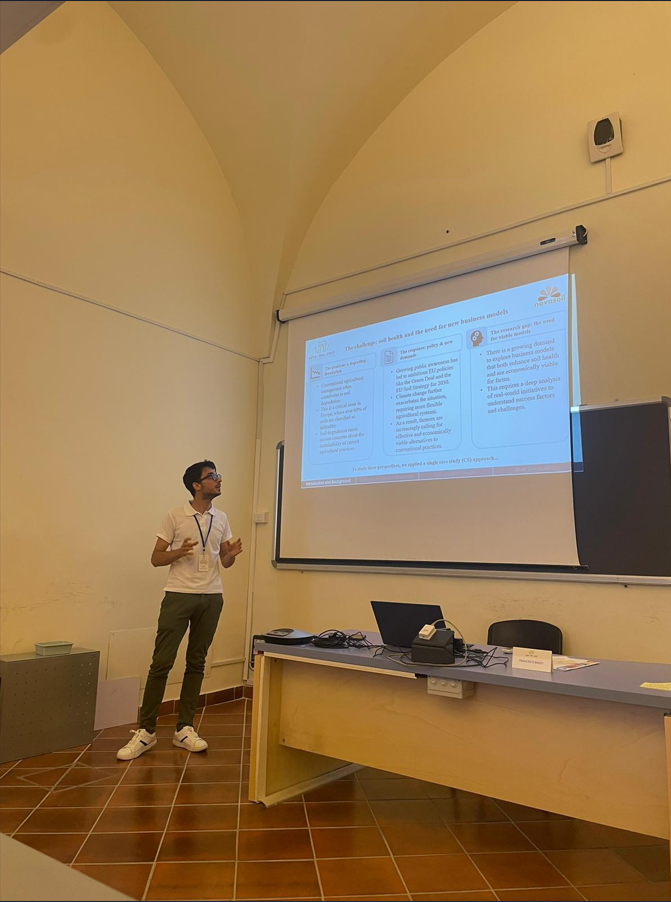

Infine, la sessione dedicata alle “Riflessioni sulla didattica disciplinare degli economisti agrari in ambiti formali e non formali” ha visto il contributo di Sonia Massari, con una presentazione dal titolo “Integrare la conoscenza territoriale nella didattica: strumenti e opportunità” e di Livia Ortolani, con la presentazione “Adeguare i curricula alla transizione agroecolgica: il progetto RIFLAESSI”, sviluppata in collaborazione con l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo ed il CREA.


L’ultima giornata si è chiusa con la sessione organizzata promossa dal gruppo padovano, con Laura Secco, Alessandra Rigo, Fabio Azzolin, Elena Pisani, Mauro Masiero, Paola Gatto (Università di Padova), che ha coinvolto anche Angela Moriggi, Valentino Marini Govigli (Alma Mater Studiorum Bologna) e Sabrina Tomasi (Università di Pisa).
Il tema “Approcci partecipativi e reti per costruire futuro” ha visto coinvoltɜ diversɜ ricercatorɜ del gruppo PAGE. La sessione ha messo al centro i metodi qualitativi e le pratiche collettive per lo sviluppo delle aree rurali. Si è passati dal caso delle Foreste Casentinesi, presentato da Valentino Marini Govigli, dove la valutazione partecipata aiuta a dirimere conflitti nella gestione forestale, a una riflessione sull’integrazione, attraverso gli approcci partecipativi, delle tre missioni dell’università, utilizzando forme di didattica innovativa per coinvolgere anche gli studenti in percorsi di co-progettazione con le comunità rurali, a cura di Sabrina Tomasi.
È stata poi presentata l’esperienza della “Piana del Cibo” di Lucca, presentata da Benedetta Bernardini: un esempio di food policy network capace di integrare politiche alimentari e co-progettazione territoriale. Si è approdati infine, con l’intervento di Daniele Vergamini, ai Transformative Labs del progetto europeo GoDigiBioS, che sperimentano approcci partecipativi innovativi per la governance della biodiversità. Nel complesso, la sessione ha evidenziato come i metodi partecipativi, stiano diventando ingredienti imprescindibili per economie rurali resilienti, sottolineando la necessità di formare reti di ricerca pratica sempre più solide e multi-, inter- e transdisciplinari.



Per il professor Gianluca Brunori questo congresso ha rappresentato suo primo anno alla guida di SIDEA: “il convegno è stato un passo importante per la riflessione su cosa significhi essere economista agrario oggi, in un contesto in cui la centralità dei temi di interesse agricolo, la loro complessità e l’urgenza di trovare soluzioni richiede pluralità di competenze, diversità di approcci, e una grande capacità di ascolto reciproco e integrazione“, dichiara.
In una riflessione collettiva, da giovani ricercatorɜ PAGE, abbiamo ragionato su cosa abbia significato per noi partecipare a questo congresso integrato delle tre società di economia agraria e cosa abbiamo appreso. Questa occasione ci ha dato modo di vivere appieno il senso del gruppo, fornendo opportunità di scambio e confronto anche con altri gruppi da altre università, trovare convergenze e ricevere spunti utili per integrare le nostre conoscenze e approcci alla ricerca. Abbiamo riflettuto sul nostro posizionamento e sulla possibilità di dare un contributo strutturato alle sfide lanciate durante le tre giornate. Per lavorare su rural proofing, imprenditorialità rurale, innovazioni sociali e transizione ecologica abbiamo chiara l’esigenza di dover continuare ad approfondire metodi e approcci di coinvolgimento territoriale e dialogo con le comunità. Per farlo, abbiamo compreso quanto sia importante continuare a perfezionarci sull’uso dei metodi qualitativi e partecipativi, necessari al settore dell’economia agraria, e studiare le giuste integrazioni con i metodi quantitativi, in un approccio aperto ai metodi misti. Questo primo congresso SIDEA-SIEA-CESET- ci ha fatto incontrare tante belle giovani menti da altre università. Abbiamo aperto un dialogo sulla necessità di confrontarci più spesso, ponendo le basi per un gruppo giovani, che da tutta Italia, possa riflettere e agire in maniera sistemica e sulle sfide emergenti.

Lasciamo Benevento con un bagaglio di idee, contatti e ispirazioni: ingredienti fondamentali per proseguire la nostra missione di supportare la transizione verso sistemi agroalimentari sostenibili e resilienti, consapevoli di essere solo all’inizio di un percorso, animatɜ da tanta motivazione di voler dare un contributo reale nei contesti che attraversiamo.

